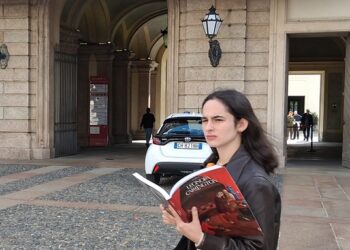A Cellatica, in provincia di Brescia, inaugurato un unicum nel suo genere, la collezione formatasi in 30 anni di appassionata ricerca di opere d’arte da parte dell’imprenditore nel settore dell’oil&gas Paolo Zani, che qui visse quotidianamente con la sua famiglia. Qui “abitò l’arte”

Cellatica (BS), Italia.
Una inaugurazione di altissimo livello culturale e piena di commozione quella dello scorso 5 febbraio a Cellatica, nella provincia di Brescia. Ha aperto i battenti al pubblico (un pubblico “selezionato“: le visite saranno soltanto su prenotazione, in piccoli gruppi, accompagnati da una guida) la Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani, con 800 capolavori di pittura, scultura e arredi francesi e veneziani.
“Oggi celebriamo la realizzazione di un sogno, di un luminare e amico – dichiara il direttore Massimiliano Cappella – dedicato alla figlia Carolina, nel giorno del suo 30esimo compleanno. Un luogo di bellezza e verità. Attraverso l’arte Paolo Zani offre a sua figlia e a tutti noi un balsamo per lenire il dolore della vita. Ogni inaugurazione è un motivo di consapevolezza per l’uomo, che nella cultura può ritrovare se stesso. Oggi sentiamo l’orgoglio e la gioia di inaugurare un percorso che resterà. Pensiamo che la collezione possa dialogare in modo trasversale con bambini, adulti, anziani. Non a caso le prime visite saranno in collaborazione con le scuole della zona. Tuttavia, questa è una collezione che va oltre il territorio, ha spirito internazionale”. La collaborazione con il comune di Caiazzo è stata fondamentale per la riuscita del progetto così come il legame con la comunità che ha partecipato con affetto al momento ufficiale, con tanto di benedizione del parroco, il monsignor Claudio Paganini, e vicinanza alla emozionatissima moglie Patrizia Ondelli, che ha ricordato del marito la sua capacità di “abitare l’arte”: “A dispetto della sobrietà di Paolo, la casa trasmette Bellezza e gioia di vivere”.

Di sobrietà e riservatezza ha parlato anche la presidente della Fondazione Zani (che sostiene la ricerca sul melanoma ed eroga borse di studio per ragazzi meritevoli) Claudia Zola: “Lo stile garbato, di un’eleganza di altri tempi di Paolo Zani si riflette in questo luogo: il silenzio di questa casa, se ascoltato, è in grado di insegnarci molto. Le famose “melodie inascoltate” di John Keats, “più dolci di quelle ascoltate”. Ogni oggetto scelto poteva raccontare una sua storia ed essere evocativo. Sapeva riaprire la porta del cuore e della fantasia, cosa che nei tempi frenetici in cui viviamo è difficile”.
Addentrarsi attraverso l’armonioso giardino nella casa trasformata, ma neanche tanto, in museo (in quella che era la cucina sono stati allestiti biglietteria e book shop, per il resto gli ambienti sono rimasti pressoché identici ai tempi in cui era abitata) ci si trova catapultati in un viaggio nel tempo e nel gusto. Sottolineato dagli scenari luminosi di “Idee…in Luce” di Claudio Cervelli. Un gusto specifico: “La casa possiede oltre 850 pezzi. L’imprenditore Zani aveva un gusto molto preciso: era attratto dal periodo che va tra la fine del ‘600 e l’inizio dell’‘800, ma già con la fine del ‘700 faceva fatica – spiega l’ottima guida– Amava il gusto barocco e rococò. Nessuno conosceva l’esistenza di questa collezione: quando invitava ospiti a cena li accompagnava al ristorante. Era molto geloso della sua casa, era davvero l’abitazione nella quale viveva con la sua famiglia”. La cura e la giustapposizione dei pezzi, talvolta di epoche o provenienze diverse, dipendeva dall’innato senso di armonia di Paolo Zani che lo ha spesso portato a comprare mobili e vasi in coppia. La prima sala è quella “del Canaletto” dove la luce dorata delle note vedute veneziane creano una realtà virtuale davvero incantevole. Spicca un quadro del 1741 di Francois Boucher, uno dei maestri del rococò francese alla corte di Luigi XV, l’“Allegoria della terra”.

Si prosegue il percorso ammirando la commode del 1750, impiallacciata in ebano, con intarsi in tartaruga e peltro su sfondo di rame, attribuita a André Charles Boulle, “ebanista del re” Luigi XV, esposto al Louvre. Poi, passando per la “Nicchia del Doge”, che oltre 50 anni dopo il Canaletto, testimonia il passaggio del Pontefice in laguna e la passione del tempo per la Chinoiserie, si entra nella scenografica sala da pranzo o “Sala del Maggiolini”, con la coppia di commode del 1789, dono di nozze, dell’ebanista di Parabiago, su progetto di Giocondo Albertolli e legni vari a intarsio su disegno di Andrea Appiani, raffiguranti il carro di Diana, allegoria della fedeltà, e Venere, allegoria della fecondità. La sala è speciale anche per la presenza di 18 sedute tutte uguali, di manifattura genovese del quinto decennio del XVIII secolo, probabilmente di disegno di Lorenzo De Ferrari, provenienti dall’asta di Yves Saint Laurent.
La sala affaccia su una sorprendente “Sala delle pietre o dei bronzi” con al centro un labrum romano in marmo del II secolo d.C. per conservare l’acqua calda. Il primo progetto prevedeva una vasca per raccogliere l’acqua piovana, poi il tetto venne chiuso con pannelli di vetro e la vasca trasformata in una piscina con l’acqua calda. Nella grandiosa sala dell’antiquariato si possono ammirare busti, vasi dell’antica Grecia, della Cina, un meraviglioso piano di tavolo romano a soggetti geometrici del XVI secolo e addirittura un’originale statua di Buddha insolitamente in piedi, del IV/V secolo d.C., della regione del Pakistan.
Si giunge, dopo il curioso bagno di arte antica, nella “Sala dell’ottagono”, cuore della casa. Una manifattura di assoluto prestigio realizzata dall’opificio delle pietre dure di Firenze alla fine del ‘600. Si tratta di un tavolo con piano ottagonale in commesso fiorentino, riccamente intarsiato a tre corone concentriche, con 33 specie di frutti, 21 di fiori, 17 tipi di uccelli e 7 di insetti, in marmo e pietre semi-preziose. La storia di questo tavolo è piuttosto rocambolesca: Zani partecipò nel giugno del 2005 all’asta di Londra e lo acquistò, poi il governo inglese esercitò la prelazione e il tavolo tornò nel Regno Unito. Successivamente, a seguito del tragico incidente della metropolitana, tutto il capitale nazionale virò sulla sicurezza e il tavolo rientrò in Italia.

Proseguendo si incontrano poi mobili veneziani; dell’ebanista fiammingo Roger Vandercruse; una curiosa collezione rinascimentale di Trapani di devozionali in corallo rosso; il bellissimo “Ritratto a mezzo busto di anziano” di Giambattista Tiepolo; i capezzali sopra le testate dei letti a motivo decisionale; il presepe dalla collezione di Umberto Agnelli della bottega dei fratelli Tipa del 1700; le sedie con i braccioli arretrati, per le gonne ampie che iniziavano a imperversare nella moda di allora e gli schienali più bassi per non disturbare le acconciature. E poi lo scrigno del 1500 con tante piccole scatole e la rappresentazione delle virtù, dono di nozze; le tele di Francesco Guardi e Bernardo Bellotto (nipote e unico allievo del Canaletto) di metà degli anni ‘70 del 1700; i bassorilievi bianchissimi di Ginori realizzati con un impasto di argilla e caolino diffuso in Cina già dal ‘600 e in uso in Italia solo dall’inizio del ‘700; il “Bacco incorona Arianna” di Giambattista Tiepolo, che sembra retroilluminato.
ll dipinto “Villa Loredan a Paese”, di Francesco Guardi, è l’ultimo acquisto di Zani, un unicum: non una veduta veneziana bensì una villa palladiana, Villa Loredana, sulla strada da Treviso a Castelfranco Veneto, commissionata dal Console britannico nel 1780. E soggetto della cartolina, edita da Poste Italiane, in tiratura limitata di 2.000 pezzi, presentata proprio il giorno dell’inaugurazione. Insieme al francobollo datato 5 febbraio 2020, creato ad hoc, per la serie “La Donna nell’arte”, raffigurante un particolare del dipinto “Nettuno offe doni a Venezia”, di Giambattista Tiepolo, conservato al Palazzo Ducale di Venezia. “Piccoli manifesti dentellati”, che resistono anche nell’era dei social.
Infine, la camera da letto, detta anche “Sala del ridotto”, con l’importante “Il Ridotto in Venezia”, di Pietro Longhi: durante il carnevale, che durava 6 mesi, il “ridotto” era casa da gioco, di appuntamenti e incontri di ogni tipo, Longhi ne restituisce un’immagine realistica e anche un po’ critica. Nella stessa stanza anche “Venere nella fucina di Vulcano”, di Francois Boucher, 1746/7, dove Venere chiede al Dio Vulcano le armi per suo figlio Enea, e le vedute veneziane di Michele Marieschi.
Una godibilissima collezione narrata con grande cura e preparazione che stupirà più di un visitatore.
Foto Elena Borravicchio
Info:
fondazionezani.com